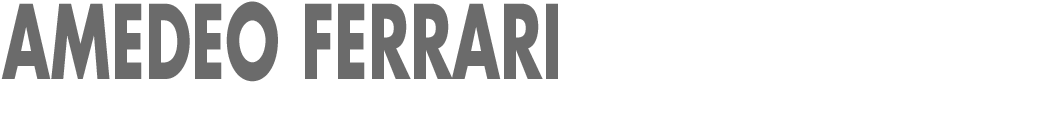Amedeo Ferrari
Caduto
Amedeo Ferrari nasce il 6 settembre 1895 a Casalpusterlengo, oggi in provincia di Lodi, da dove molto presto la sua famiglia si trasferisce a Monza. Combattente durante la Prima guerra mondiale, al ritorno si dedica all’impegno politico come militante socialista per passare poi, dopo la scissione del partito, nelle fila del nuovo Partito comunista d’Italia del quale insieme ad altri dieci concittadini fonda la sezione monzese già nel 1921. Sono gli anni dello squadrismo fascista al quale Ferrari nel 1922 paga il prezzo di un’aggressione mirata nei suoi confronti a colpi di manganello. Nel luglio del 1927 viene arrestato e deferito al Tribunale speciale che il 25 ottobre 1928 lo condanna a due anni di reclusione per aver partecipato a riunioni clandestine con il proposito di ricostituire il Partito comunista in Brianza, pena che sconterà per buona parte nel penitenziario di Nisida. Tornato a Monza dopo la scarcerazione, vive per lo più solo perché la moglie, Paola Gianella, sta pagando la sua attività politica antifascista con lunghi anni di confino. Nel 1936 Amedeo si trasferisce in via Amati, a questo punto la sua casa diviene il punto di riferimento per tutti i comunisti monzesi ma anche dei paesi del circondario. Gli appartenenti al partito clandestino fanno capo a lui per organizzare riunioni nelle quali si discute la situazione politica del momento e operativamente per organizzare e sostenere le cellule che si diffondono nelle fabbriche della zona. Sono questi gli anni in cui stringe anche lo stretto sodalizio con il personaggio emergente del comunismo brianzolo, Gianni Citterio, e con gli esponenti di altre forze politiche antifasciste, soprattutto con i socialisti Gambacorti Passerini e Carlo Casanova e con il comunista Scali. Per coprire la propria attività, Ferrari crea una società sportiva, la “Giovani calciatori” che prende sede presso il Caffè Venturelli in via Amati. Dallo scoppio della guerra in avanti Ferrari guida il movimento clandestino non solo in termini organizzativi ma anche operativi, con azioni di propaganda per la distribuzione di volantini antifascisti stampati con un piccolo ciclostile nascosto ad Omate e con scritte sui muri con la vernice effettuate da piccole squadre di notte. Gli eventi del 25 luglio e 8 settembre 1943 lo vedono in prima fila nelle manifestazioni che interessano Monza in quei frangenti ma, con l’imminente arrivo dei tedeschi, Ferrari a 48 anni prende una decisione coraggiosa ma pienamente coerente con tutto quello che è stato il suo impegno contro la dittatura fino a quel momento, si unisce alle primissime bande partigiane al Pian dei Resinelli. In considerazione della scarsità di armi e soprattutto della facilità con la quale queste zone potevano essere circondate dai tedeschi, questi primi raggruppamenti furono presto scompaginati e già a gennaio del ’44 Ferrari deve abbandonare la Valsassina; il partito lo invia in Val Grande, nell’Ossola.
Anche Amedeo Ferrari come tutti i componenti delle formazioni partigiane di quella valle, verrà travolto dal rastrellamento del giugno 1944. In fuga con altri due compagni, arriva il 19 giugno nei pressi dell’Alpe Onunchio, gli uomini sono spossati e in preda alla fame. Fondamentale per ricostruire gli ultimi momenti della vita dell’antifascista monzese, è la testimonianza di Marianna Rossi, componente di una delle due famiglie di Intragna che in quel momento erano al lavoro stabile all’Alpe, raccolta il 23 gennaio 1981 da Teresina Rossi. “Quel mattino vedemmo arrivare i tre partigiani, uno era anziano, uno moro e uno biondo. Quest’ultimo teneva in mano un sacchetto di riso e ci chiese se potevamo cuocerlo. Noi ci eravamo già accorti che i soldati tedeschi dalla Baiessa stavano venendo qui a Onunchio. Avvertimmo i tre che i tedeschi stavano arrivando e non potevano fermarsi; allora se ne andarono in su. Subito dopo passarono i tedeschi che proseguirono per la direzione che avevano preso i tre. Dopo un pò sentimmo alcune raffiche. Poi i tedeschi tornarono all’Alpe Onunchio e vi rimasero tre giorni, però non ci fecero niente. Quando se ne andarono salimmo sopra Onunchio e sulla porta di una baitina per le pecore scoprimmo il corpo del ragazzo moro. Dentro c’erano gli altri due, l’uomo anziano aveva il petto squarciato dalle pallottole. Si vede che i tre partigiani si erano nascosti nella piccola costruzione sperando che i nazisti non arrivassero fin lì”.
Il luogo preciso in cui sorgeva la baita è individuato dal partigiano Luigi Filippini, compaesano di uno dei uccisi che dopo otto giorni recuperò le salme, nella località Forcora al Pizzo Marona. Gli altri due caduti erano appunto Luigi Giudici di Solbiate Olona ed Enrico Patani di Cerro Maggiore.
FONTI
Arienti Pietro, Monza dall’armistizio alla Liberazione: 1943-1945, Missaglia, Bellavite editore, 2015.
Nino Chiovini, Piccola storia partigiana della banda di Pian Cavallone, Tararà, 2014.